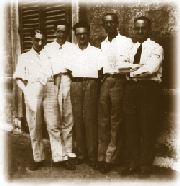 Ben presto fu
chiamato a collaborare con Fermi Franco Rasetti, titolare della cattedra di Spettroscopia.
Si unirono, entro la fine del 1927, un gruppo di studenti della facoltà di Ingegneria.
Primo fra questi Emilio Segrè a cui seguirono Ferretti, Wick, Ettore Majorana, Bruno
Pontecorvo e infine il chimico D'Agostino.
Ben presto fu
chiamato a collaborare con Fermi Franco Rasetti, titolare della cattedra di Spettroscopia.
Si unirono, entro la fine del 1927, un gruppo di studenti della facoltà di Ingegneria.
Primo fra questi Emilio Segrè a cui seguirono Ferretti, Wick, Ettore Majorana, Bruno
Pontecorvo e infine il chimico D'Agostino.L'Istituto di Fisica di Roma possedeva oltre a spettroscopi classici, anche i più avanzati spettrografi di Hilger ed una sufficiente attrezzatura ausiliaria. Il gruppo di Fermi poteva disporre inoltre dell'ottima strumentazione dell'Istituto Fisico della Sanità Pubblica, ospitato nell' edificio di via Panisperna.
Negli dal 1927 al 1931 si stablì un fecondo rapporto di lavoro tra Fermi e Rasetti che determinò un grande impulso all'attività di ricerca volta al campo della fisica atomica e molecolare.
Durante questo periodo il contributo di Fermi alla teoria quantistica fu di grande importanza, non tanto nella formulazione dei principi quanto piuttosto nell'approfondimento e nell'applicazione di tali principi.
Fermi e Corbino, compreso che la fisica atomica diveniva spostarono quindi l'attenzione.
Il Gruppo di Fermi e la Sperimentazione con i Neutroni
Gli anni dal 1934 al 1936 furono il periodo glorioso della scuola romana; Fermi e il suo gruppo si dedicarono alla ricerca sperimentale delle reazioni nucleari provocate da neutroni, giungendo alla scoperta della radioattività indotta dai neutroni e delle notevoli proprietà dei neutroni lenti. Per questo lavoro Fermi fu insignito del premio Nobel per la fisica nel 1938.
Alcuni cimeli e strumenti relativi a questa fase della ricerca sono ancora conservati nella sala del museo di fisica dedicata a Fermi all'università "La Sapienza" di Roma. Piccoli contatori Geiger-Muller, vari materiali usati nella sperimentazione sul nucleo ed alcune lettere che vi si riferiscono; apparecchiature utilizzate per la rivelazione delle particelle e per la misura della radioattività.
La scoperta da parte dei coniugi Joliot e Curie sulla possibilità di ottenere artificialmente un nuclide radioattivo (bombardano con particelle a ua lastra di alluminio ottenendo così un isotopo del fosforo non esistewnte in natura 15P30 -> 14Si30 + 1e0 + v )suggerì a Fermi la possibilità di bombardare i nuclei utilizzando neutroni, molto più penetranti in quanto privi di carica elettrica. Secondo l'idea di Fermi infatti, questi avrebbero dovuto raggiungere il nucleo senza subire la repulsione elettrostatica, neppure nel caso di nuclei pesanti dotati di una elevata carica elettrica positiva.
La sorgente di neutroni ottenuta da una miscela di radon e polvere di berillio, sigillata al'interno di un tubo di vetro, veniva posta dentro un cilindretto contenente il materiale da irradiare. Il cilindretto veniva a sua volta racchiuso in un pozzetto di piombo al fine di schermare la radiazione gamma della sorgente. Dopo un certo tempo di irradazione il cilindretto veniva portato in un ambiente privo di sorgenti radioattive al fine di misurare l'intensita dellaradiazione indotta. Le misure venivano eseguite mediante un contatore Geiger-Muller o con una camera a ionizzazione collegata ad un elettrometro di Edelmann, la cui lettura permetteva di risalire all'intensità della corrente, proporzionale all'attività.
Gli esperimenti diedero presto esiti positivi e nel marzo del 1934 fu annunciata la scoperta della radioattività indotta da neutroni. Seguì un febbrile lavoro di ricerca in cui furono bombardati i nuclei di più di sessanta elementi. In pochi mesi il gruppo romano, a cui proprio in quel periodo si era unito il chimico Oscar D'Agostino, aveva ottenuto oltre quaranta nuovi isotopi radioattivi. Molti dei prodotti radioattivi furono individuati chimicamente e furono chiarite le reazioni nucleari che li avevano originati.
Fermi, pur occupandosi della direzione del lavoro e dell'interpretazione teorica dei risultati, prendeva parte egli stesso agli esperimenti, partecipando inoltre alla costruzione dei pezzi di laboratorio.
Ma le scoperte non finirono qui: nell'ottobre del 1934, nel corso delle esperienze sulla radioattività provocata da bombardamento di neutroni, i ricercatori poterono osservare che la radioattività diveniva più intensa se i neutroni venivano rallentati facendoli passare attraverso una sostanza ricca di idrogeno, come l'acqua o la paraffina.
Il fenomeno fu interpretato da Fermi appena poche ore dopo la sua scoperta: il rapido rallentamento dei neutroni, dovuto alla perdita di energia causata dagli urti successivi con i nuclei dell'idrogeno, aumentava la probabilità che il neutrone, restando più a lungo nelle vicinanze del nucleo, ne venisse assorbito con la conseguente attivazione del processo nucleare.
Le pionieristiche ricerche di Fermi costituirono anche il punto di partenza per la scoperta della fissione nucleare. Fermi aveva bombardato infruttuosamente l'uranio 92 nel tentativo un nuovo elemento artificiale di numero atomico 93. Qualche anno dopo, nel 1938, a conclusione delle ricerche di Lise Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassman, che avevano ripreso gli studi di Fermi, si ebbero i primi indizi sulla scissione di nuclei di uranio, in due frammenti di massa confrontabile. Il nucleo dell'uranio, assorbendo un neutrone, si spaccava in due liberando una eccezionale quantità di energia.
[Pagina Iniziale]
[Vita]
[Principali
Lavori] [Principali Collaboratori]