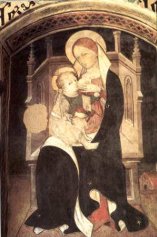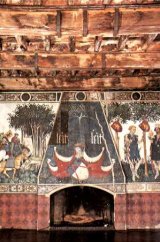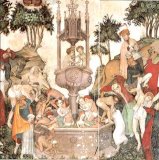Giovedì 6 Aprile 2000: Castello della
Manta, Saluzzo, Abbazia di Staffarda
(Lara Meneghin e Stefano Cirella)
Filmati di Marta Landonio; elaborazione di Davide Macchi (4^B)
6:10 Nonostante le raccomandazioni della Carla, il panino-commediografo e il
rappresentante di 3E sono riusciti a ritardare la partenza di ben10 minuti.
6:15 - 9:30 Molti sono ancora tra le braccia di Morfeo, quelli svegli cercano di
ampliare la cultura musicale delle prof, proponendo musica truzza, i Queen della Marta
(che gran successone hanno riscosso!), e, come gran finale, la "melodiosa"
musica di Ricky.
9:30 Si arriva! E dopo una sosta prolungata per lo svuoto dei serbatoi, si sale al
Castello.
9:45 Dopo l'esibizione dei nostri espertissimi tiratori di freesby (Ricky e Marco F.),
riusciamo finalmente ad entrare nel Castello.
10:00 - 10:40 La nostra guida (prof.ssa Cantù) ci illustra le
particolarita' stilistiche del soffitto della Sala delle feste, della Galleria e della
Sala baronale. Una delle eroine (Sinope) viene "accidentalmente" paragonata,
telepaticamente, dalla guida e dal folletto sclerato (Stefano C.), alla Venere di
Botticelli. La piu' grande attrazione è la Fonte della giovinezza: uno dei sette nani,
rosso in viso, con tanto di libretto, si presta a tradurre le varie iscrizioni in un
religioso silenzio.
Nell'atrio dei trofei di caccia baldanzosi giovinotti di 4E si
divertono a provare le varie paia di corna (?!).
10:45 Usciti dal castello e ritornati al mercatino, gli intenditori di formaggi
consigliano quali caciotte comprare…Sui pullman! Si parte per Saluzzo!
11:05 Ci si incammina per la Chiesa di S.Giovanni. Quali "mistiche"
corrispondenze trova la nostra guida tra le caratteristiche interne della Chiesa e le sue
note informative!
12:05 Dopo un'accurata visita all'abside, ci si sposta a Casa Cavassa.
12:20 Finalmente si pranza! I buongustai, capeggiati dal pozzo-senza-fondo Checco,
vanno alla ricerca di una tipica trattoria, gli altri vanno alla ricerca di un
parco........
14:40 Si parte per l'Abbazia di Staffarda.
15:40 - 16:40 Siamo accolti dalla tipica aria pura di campagna; una
guida ci accompagna al chiostro e, simpaticamente, ce lo fa attraversare in fila indiana
e, per di più, in silenzio. Si visitano le varie sale, tipiche dei monasteri cistercensi,
in stile romanico.
Dopo un piccolo break, visitiamo la Chiesa. C'e' chi si diverte a
salire sul pulpito, chi suona la campanella e chi ci richiama al silenzio. Ultima tappa:
la Foresteria, la sala in cui veniva offerto cibo ai pellegrini: sui capitelli delle
colonne interessante la rappresentazione delle fasi della Creazione.
16:45 - 19:55 Sulla via del ritorno…..
Attacco vigoroso delle mosche: ognuno cerca di eliminarle con i mezzi a
disposizione, tendine, fogli, scarpe…
La redattrice, Lara, non avendo di meglio da fare, con la
collaborazione di Marco, progetta uno scherzo a Matteo, il conquistatore specializzato nel
far capitolare donne mediterranee. Marco, dunque, chiama Matteo sul cellulare: finge di
essere il ragazzo cornificato da lui, inveisce, lo bistratta, gli rivolge velate minacce.
Il grande conquistatore si smarrisce, si spaventa, sta perdendo la bussola: una cosa così
non gli era mai capitata! Interviene in sua difesa l'amico Giacomo. Le cose vanno per le
lunghe (ci sono ancora molti chilometri!); lo scherzo si protrae, mentre i soldi del
cellulare diminuiscono… Alla fine urliamo tutti in coro al cellulare, ma il
malcapitato non capisce ancora che siamo noi gli autori dello scherzo... In fondo Matteo
presume d'essere un grande conquistatore, non ha mai detto d'essere un acuto e perspicace
Sherlock Holmes!
20:00 Ed eccoci arrivati: puntuali come perfetti orologi svizzeri.
Inizio pagina
Album Fotografico
Home Page
|

La nostra guida......

"Processione" al Castello della Manta

Sala delle feste

Galleria

Atrio con trofei di caccia
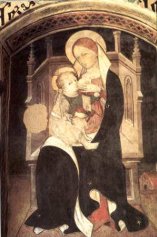
Affresco della Sala interna
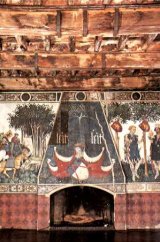
Camino della Sala baronale

Sinope

Carlo Magno

Goffredo di Buglione

Tamiri
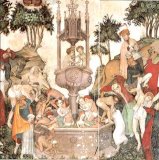
Fonte della giovinezza

Saluzzo

Campanile

Chiesa di S. Giovanni
(filmato facciata)
(filmato sala del chiostro)

Sarcofago con Ludovico II

Particolare dell'abside

Portale di Casa Cavassa

"Salita al Castello" con Pate e donna

Abbazia di Staffarda
(filmato)

La Chiesa

L'interno della Chiesa

L'altare della Chiesa

Gruppo ligneo con Cristo in croce

Il Chiostro

La Foresteria

L'interno della Foresteria




I Capitelli della Foresteria
|
CASTELLO DELLA MANTA
(FILMATO)
Sorge in cima ad un colle fra Saluzzo e Cuneo.
Già nel XIII secolo esisteva un primo nucleo fortificato rafforzato nel XIV secolo dai
marchesi di Saluzzo . In questo periodo il castello era caratterizzato da un possente
mastio rettangolare circondato da mura di cui oggi resta visibile solo la torre cilindrica
e parte del mastio.
Nel 1416 eredita il marchesato Valeriano, figlio naturale di Tommaso III di Saluzzo, che
inizia il ramo dei Saluzzo Manta che, nel corso dei secoli, trasforma la struttura
militare in una dimora signorile.
Valeriano intraprende lavori di ampliamento ed arricchimento del castello che inizia a
svolgere, soprattutto, una funzione di rappresentanza; egli fa costruire attorno al mastio
ed alle mura trecentesche tre corpi , in uno dei quali inserisce un salone, quello del
secondo piano, detto "Salone baronale", trasforma i giardini, facendo piantare
in quello di "meriggio" ulivi, limoni, aranci, colleziona opere d'arte e
documenti storici, chiama artisti alla sua corte.
A metà 500, poi, Michele Antonio di Saluzzo fa costruire, addossato alla parete
occidentale del castello quattrocentesco, il proprio appartamento, caratterizzato dal
grandioso salone, detto "Salone delle Grottesche", dal lungo corridoio che lo
collega alla camera da letto e da uno scalone di marmo che conduce al piano superiore: la
risistemazione vuole sottolineare il prestigio e l'importanza della famiglia, per questo
è particolarmente curata nelle decorazioni.
Il Salone, infatti, ambiente specifico di rappresentanza,
ed il corridoio hanno i soffitti decorati da affreschi e stucchi; in particolare il
soffitto del salone è affrescato al centro con la caduta di Fetonte e con 12 ovali (2 al
centro e 12 sui lati) con raffigurazioni simboliche e motti, illustranti virtù, qualità
della famiglia, inoltre gli affreschi sono contornati da decorazioni pittoriche
grottesche, tipicamente rinascimentali, ispirate da figurazioni parietali di ville
dell'antica Roma. I pavimenti del corridoio e della camera da letto conservano tracce
della decorazione originaria policroma.
Il castello, con l'estinguersi della casata Saluzzo Manta
nel 1793, entra in decadenza; esso fu restaurato verso il 1860 dai nuovi proprietari, i
conti Radicati di Marmorino, da cui discende Elisabetta Provana del Sabbione che nel 1984
dona l'edificio al Fondo per l'ambiente italiano.
CICLO DI AFFRESCHI
Il Salone baronale di Valerano, di forma rettangolare, presenta sulla parete di ponente,
di fronte al trono baronale, un grande camino con lo stemma della casata sormontato da
un'aquila e dallo stemma di famiglia e sui lati un ciclo di affreschi, che costituisce un'
importante testimonianza, in stile tardo gotico, della civiltà cortese, ciclo che è
stato restaurato, con il contributo della Olivetti di Ivrea, nel 1989.
Gli affreschi, eseguiti dopo il 1420 da uno sconosciuto maestro, chiamato "Maestro
della Manta", di cui non si conoscono altre opere, hanno soggetti tipici del tempo e,
in particolare, rivelano un forte influsso della cultura francese del '300-'400: erano,
infatti, molto stretti, per motivi politico-miltari, i rapporti tra il marchesato e la
corte francese, da qui la tendenza ad assorbire mode, costumi, gusti di quella terra:
così, alla corte di Saluzzo, si parlava in francese, ci si vestiva alla parigina, si
leggevano e si collezionavano opere d'arte francese.
Il ciclo è ispirato dal romanzo cavalleresco, di carattere didascalico-allegorico,
composto dal padre di Valerano, Tommaso III, intitolato "Il cavaliere errante"
che narra le vicende di un cavaliere cortese che insegue, idealmente, l'amore, la
ricchezza e la potenza, ma scopre la vanità della sua ricerca e, per questo, incomincia a
lottare per il bene ed il giusto. Durante i suoi viaggi, egli giunge al palazzo della dea
Fortuna ove risiedono nove potenti principi dell'antichità e nove eroine: è questa la
fonte specifica di ispirazione degli affreschi.
A destra del camino sono affrescati, appunto, nove eroi e, poi, nove eroine, ad altezza
quasi naturale, in abiti sfarzosi tipici del tempo, sotto cui indossano l'armatura; tutti
impugnano un'arma offensiva; le figure sono separate da un alberello di essenze sempre
diverse ai cui rami è appeso uno scudo.
I nove personaggi maschili rappresentano i nove marchesi di Saluzzo (il nono è Valerano)
e le nove figure femminili, tutte d'aspetto giovanile, sono le loro rispettive mogli.
Il primo personaggio a lato del camino Ettore, con lo sguardo rivolto verso i componenti
della sua dinastia è Valerano; Alessandro Magno è Tomaso III, con l'indice della mano
destra indicante il suo figlio illegittimo; Federico II, con capelli e barba lunghi e
bianchi, è Giulio Cesare; Giosuè, con la mantella riccamente decorata, è Tomaso II; il
re Davide, con il testo biblico, è Federico I; Giuda Maccabeo è Manfredo IV; re Artù è
Tomaso I; Carlo Magno è Manfredo III;Goffredo di Buglione è Manfredo I.
Pentesilea, cioè Clemenzia Provana di Pancalieri, moglie di Valerano, è ritratta sul
alto di levante della sala baronale; alla sua destra è collocata Teuca, cioè Margherita
de Rouchy, moglie di Tommaso III; Tamiris raffigura Beatrice di Ginevra, moglie di Giulio
Cesare; Lampeto, la regina delle Amazzoni, è la moglie di Tomaso II, Riccarda di Sicilia;
Etiope, ritratta nell'atto di pettinarsi, impersona Beatrice Visconti, moglie di Federico
I; Semiramide, leggendaria regina dell'Assiria, è Aloisia di Ceva, moglie di Manfredo IV;
Ippolita, una delle regine delle Amazzoni, è la moglie di Tomaso I, Beatrice di Savoia;
Sinope, dai lunghi capelli, corrisponde ad Alasia di Monferrato, moglie di Manfredo III;
infine Delfide, madre di Diomede, è Eleonora di Arborea, moglie di Manfredo I, primo
marchese di Saluzzo.
I ritratti, in origine, erano molto più sfarzosi, dato che erano decorati con corone,
gambali, elmi, guanti in metalli preziosi, il che conferma la funzione autocelebrativa del
progetto iconografico.
LA FONTE DELLA GIOVINEZZA
Sulla parete delle finestre compare un motivo tipico dell'arte "cortese", la
Fontana della Giovinezza. La fonte ispiratrice dell'affresco è una copia manoscritta,
conservata nella biblioteca di Tomaso III, del "Roman de Fauvel", un testo del
XIVsecolo. Fauvel, un essere umano con testa equina, dopo molte avventure, sposa la
Fortuna e con lei si dirige verso la Fontana della Giovinezza per ritrovare nelle sue
acque energie e forze. L'affresco, voluto anch'esso da Valerano, è formato da tre scene:
il triste corteo degli sciancati e dei vecchi; il bagno nella fontana; la riconquista
della giovinezza . All'aspetto patetico e sarcastico della sfilata degli imperatori, dei
vescovi, delle regine e dei vecchi, che si affannano a raggiungere la fontana, superando
ogni difficoltà, si oppongono le scene leggiadre, tipiche della civiltà cortese, che
nascono dalle ritrovate energie e dai rinati desideri giovanili: immergersi nella fontana
significa rinnovare l'energia fisica, ritrovare allegria, gioia d'amare, significa,
quindi, dedicarsi a cacce, tornei, amori.., a tutti quei passatempi che riempivano le
giornate di Valerano e della sua corte.
Anche in questo caso è ignoto il pittore, tuttavia gli studiosi ritengono che questo
dipinto è posteriore al ciclo degli eroi e che risale al 1444.
SALUZZO
Saluzzo, una delle città piemontesi tra Torino e Cuneo, a ridosso della catena alpina
(Monviso), è divisa in una parte bassa, moderna, e in una parte alta d'impronta
medievale. Nata verso il 1000, divenne nel 1142 capitale di marchesato.
Essa nel Medioevo divenne famosa anche per la novella del "Decameron" di
Boccaccio (X, 10 ) del marchese di Saluzzo e della virtuosa moglie Griselda.
Nel periodo romanico era già munita di fortificazioni e cinte murarie e di quel periodo
ci è giunta una serie di edifici disseminati nel primo nucleo abitato cresciuto alla base
del castello marchionale detto Castiglia, eretto nel 1270 (cappella di S. Lorenzo 1192;
chiesa di S. Martino, già esistente nel 1235, di cui resta in piedi il campanile
romanico; l'abbazia di Staffarda).
Il periodo gotico e quello rinascimentale, soprattutto per quanto riguarda l'architettura
civile, sono i più significativi nella storia della città.
Quasi alla sommità delle più bella via di Saluzzo vecchia, Salita al Castello,
fiancheggiata da case quattrocentesche con finestre bifore o crociate, con decorazioni in
cotto e affreschi a chiaroscuro sorgono il Palazzo del comune edificato nel 1482 sotto
Ludovico I con la torre e accanto la Casa delle Arti, anch'essa di fine '400, sulla cui
facciata sono rappresentate Aritmetica, Geometria, Astronomia, Musica, Grammatica, Storia,
Retorica e Dialettica.
I monumenti più significativi sono, comunque, la chiesa di San Giovanni in stile gotico e
Casa Cavassa del periodo rinascimentale.
LA CHIESA DI SAN GIOVANNI
Nel 1467 la facciata fu spostata in avanti e fu realizzato il grande chiostro
quadrato: su una parete si nota il bassorilievo in cotto di F. Filiberti
"Visitazione"; i capitelli delle colonne portano gli stemmi delle famiglie che
contribuirono alla costruzione; lungo il porticato si aprono le porte del Refettorio con
pitture rinascimentali e la sacrestia nella quale fu custodita fino al 1542 una spina
della Corona di Cristo portata a Saluzzo dal marchese Tommaso III; da un fine portale in
marmo e da una porta in legno a rilievi si accede alla cappella funeraria della famiglia
Cavassa, eretta nel 1510 dal figlio Francesco per il padre Vicario Galeazzo morto nel
1483, sul fastigio a squame sta l'immagine di San Girolamo e sul basamento sono scolpiti
finissimi bassorilievi con i simboli cristiani del pellicano e della fenice.
Tra il 1480-1487 fu aggiunta un'abside a cappella funeraria marchionale in stile gotico
francese : i pilastrini con guglie e fioroni che si prolungano negli archi doppi, le
sottili nervature e lo slancio della volta, i ricami di pietra sparsi ovunque trasmettono
un'idea di estrema leggerezza; di rilievo fra i particolari scultorei i busti reggimensole
nelle grandi nicchie e nella edicoletta di destra, il ciborio a sinistra, la cui base reca
scolpita l'impresa araldica di Ludovico II "Ne pour ce" di duplice
interpretazione "non per questo"(sole, nuvole,pioggia)/ "nato per
questo"(corona di spine, stille di sangue); nella nicchia di sinistra la figura in
marmo del marchese Ludovico II del 1504, opera di Benedetto Briosco, è rappresentata
giacente su un sarcofago a lesene e figure di Virtù, opera di Pietro da Rho, l'ottava
cornice contiene la dedica della vedova Margherita di Foix che attesta la sua fedeltà al
marito. A metà 600 fu sistemata la cappella del Rosario, la seconda a sinistra, di stile
barocco che ha una grande struttura in legno dorato che si alza fino alla cupoletta ornata
di stucchi e pitture, opera dei fratelli Botto di Savigliano; fra le colonne è posta
un'ancona rinascimentale del 1535 di Pascale Oddone con al centro la Madonna della
Misericordia che protegge la corte di Saluzzo dell'epoca con il marchese Francesco ed ai
lati Ester e Giuditta; nella predella vi è la visione di Saluzzo con le sue mura, forse
all'epoca dell'assedio che i Savoia posero alla città nel 1487.
Il tabernacolo dell'altare maggiore in legno dorato è del XVI secolo.
CASA CAVASSA
Questo palazzo a metà '400 venne in possesso di Galeazzo Cavassa, vicario generale del
marchesato ed intorno al '500 fu abbellita dal figlio Francesco con facciata a finto
bugnato con una serie di finestre su due piani, in parte ogivali e in parte crociate alla
maniera rinascimentale e con il portale in marmo, opera di Matteo Sanmicheli. Il portale
presenta scolpite nelle lesene classicheggianti sole e piante, simbolo di vitalità, lo
stemma con il pesce chavasse (dialetto lionese) che risale la corrente ed il motto
"Droit quoi qu'il soit" ("Avanti a qualunque costo"), simboli della
famiglia Cavassa.
Di pregio è la porta intagliata, un significativo esempio di ebanisteria piemontese del
XVI secolo. Nell'interno ha un cortiletto a portico su colonne e loggia.
Alla fine '800 fu acquistata dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio che la restaurò
nelle forme originarie e la donò al Comune; dal 1891 è Museo civico.
ABBAZIA DI STAFFARDA
IL COMPLESSO ARCHITETTONICO
La costruzione di Staffarda, almeno nell'ampia
articolazione che conosciamo noi, crebbe lentamente, di certo per tutto il XIII secolo,
via via con quelle parti che l'aumentata ricchezza e il più esteso potere dell'Abbazia ne
creavano la necessità. La chiesa abbaziale, in stile romanico-gotico, è a pianta
basilicale, suddivisa in tre navate da pilastri compositi, ed è conclusa da tre absidi
semicircolari, di tipo lombardo, coperte da semicatino, in contrasto con le norme
cistercensi che volevano absidi rettangolari. All'esterno, il profilo sotto il tetto è
percorso da archetti ciechi e la superficie è divisa in tre campiture da esili lesene.
Ciascuna ospita un'alta finestra ad arco a tutto sesto. Molto probabilmente, le idee e le
aspirazioni delle nuove linee gotiche portate d'oltralpe dai monaci che per primi
governarono l'Abbazia ed ebbero potere decisionale nella sua costruzione, si scontrarono
con una realtà diversa, contingente e difficilmente superabile: la tradizione delle
maestranze use ai modi costruttivi romanici. Le due situazioni trovarono un punto di
superamento in quella particolare tipologia architettonica assunta appunto da Staffarda.
Di tipo chiaramente lombardo, ancora romanico, possono essere infatti considerate le
absidi, la parte probabilmente più antica di tutta la costruzione. Poi, lentamente, i
moduli si svilupparono verso più accentuate caratterizzazioni gotiche. La sensazione
complessiva dell'interno è più gotica che romanica, anche se molti archi sono a pieno
centro. Al secondo pilastro di sinistra è agganciato uno splendido pulpito ligneo, di
raffinate eleganze gotiche, databile alla fine del XV secolo. Ignoto è l'artista che lo
eseguì, come sconosciuto è l'autore dell'eccezionale coro della stessa Abbazia.
Sull'altare maggiore, nell'abside centrale, vi è un grande polittico di Oddone Pascale.
Sul muro della quarta campata della navata destra, vi è un gruppo ligneo scolpito e
dipinto. Sul lato destro della chiesa si erge un alto campanile, costruito in data
imprecisata, ma sicuramente non dopo il XV secolo. Il campanile presenta una solida punta
aguzza poggiata su un basamento quadrato a più piani scanditi da archetti.
La facciata della chiesa abbaziale si presenta oggi in forma imponente, ma certamente non
originaria, in quanto sottoposta, già in epoca antica, a vari rimaneggiamenti. Il
Chiostro, di stile gotico, è costituito da porticati che si aprono ad arco su doppie
colonnine con capitelli ben lavorati. Al centro c'è il giardino e a sud l'elegante Sala
Capitolare. All'esterno del nucleo centrale e principale dell'Abbazia, il monastero si
articolava in diverse altre costruzioni, tutte funzionali alla sua caratterizzazione di
grande azienda agricola.
IL GRUPPO LIGNEO CON CRISTO IN CROCE
Il gruppo ligneo rappresenta in alto al centro
Cristo in croce, a sinistra la statua della Vergine dolente, a destra quella di San
Giovanni. Attribuito in passato ad un artista locale di grande levatura, del quale per
altro non esistono testimonianze di analoghi risultati in altre opere, il gruppo è più
probabile lavoro di uno scultore di area franco-tedesca come lascerebbero intendere i
nervosi intagli dei panneggi. Per altro, le eleganze dei volti e degli atteggiamenti
porterebbero a non escludere la mano di un artista italiano. Cristo in croce, la Madonna e
San Giovanni furono probabilmente scolpiti nel primo ventennio del XVI secolo. Di grande
potenza emotiva, l'autore pare muoversi infatti tra il ricordo dell'ultimo gotico
internazionale e i primi, consistenti influssi di un Rinascimento di tipo tedesco. Il
gruppo ligneo fu realizzato per un'altra parte della chiesa abbaziale di Staffarda e
collocato nell'attuale posizione in un secondo tempo.
STORIA
L'abbazia fu eretta per volontà del Marchesato
di Saluzzo. La data della sua fondazione si può collocare tra il 1135 e il 1138. I monaci
fondatori provenivano dall'Abbazia di Tiglieto, in Liguria e sul terreno a loro donato,
"la staffarda" fondarono prima la Chiesa e poi la loro casa.
Come voleva la tradizione cistercense i monaci si dedicarono subito ai lavori di bonifica
dei terreni. Le donazioni di terre, censi e beni a favore dell'abbazia furono consistenti.
L'abbazia conserva tuttora l'aspetto di un vero e proprio paese. Sono tutt'oggi visitabili
la chiesa, il chiostro, il refettorio, l'edificio dei conversi, la foresteria, il mercato
e le cascine.
Nel corso dei secoli Staffarda si costituì come un nucleo autonomo di attività
preindustriale in grado di fornire prodotti destinati sia all'uso interno che alla loro
commercializzazione. Sul piano economico i Cistercensi influirono notevolmente sul
progresso della civiltà. Tutti quelli che lavoravano sui loro possedimenti avevano la
possibilità di diventare uomini liberi. In questo modo l'ordine accelerò il processo di
scomparsa della servitù della gleba.
Verso il XV secolo cominciarono a decadere sia le opere materiali che quelle spirituali
così vive nell'antico cenobio. Nel 1606 si tentò di innestare a Staffarda i monaci della
congregazione benedettina-cistercense dei " Foglianti", nel tentativo di
riportare il cenobio al primitivo ardore di opere materiali e spirituali. La vita
religiosa cominciò velocemente a decadere verso la fine del XIII secolo e fu una parabola
discendente progressiva e inarrestabile. L'abbazia fu data in commenda a laici o
ecclesiasti di poco scrupolo interessati solo ai proventi economici del complesso. Nel
1750, in seguito alle trattative tra Santa Sede e Corte Sabauda, con bolla pontificia
Benedetto XIV dichiarò decaduta la "mensa abbaziale" autonoma concedendo
l'intero complesso di Staffarda (monastero, beni e terre), in commenda perpetua all'Ordine
Mauriziano. Soppressa con decreto napoleonico del 31 agosto 1802, dopo la Restaurazione
l'Abbazia rientrò tra i beni del Mauriziano, di cui fa ancora parte. Importanti lavori di
restauro e di ripristino furono compiuti tra il 1826 e il 1840, altri vennero iniziati nel
1920. Già dal 1804, la chiesa abbaziale venne adibita a parrocchiale di questa frazione
di Saluzzo. Staffarda, oggi ha un grande valore artistico per la sua equilibrata
commistione di stile romano-gotico ed è una pagina importante della storia dei monaci
Cistercensi e delle loro opere.
Note informative e immagini tratte da:
"Il castello della Manta",a cura di L.Botta, A.Gedda, M.Serra, Editurist,
supplemento al n. 44 di "Piemonte tuttovacanza"; "Castello della Manta,
note e immagini", a cura di M.Magnifico, 1990, Electa; "Castello della
Manta", a cura di A.Piovano, D.Brizio, C.Novara, 1989, Gribaudo Editore;
"Saluzzo e i dintorni, guida storico-artistica e turistica", a cura di
G.Gerbotto, A.Tetti, Edelweiss-Saluzzo; "Bell'Italia", n.86 giugno 1993,
"Profumo di capitale" di P.L.Berbotto, pagg. 66-83;
http://www.piemonteonline.it/; http://www.regione.pmn.it/.
|